PAGELLA DI GIUDA
È arrivato il momento di dire che La quarta versione di Giuda non è meno bello di La ricreazione è finita e quindi merita la sua stessa fortuna e considerazione.
Un anno fa usciva il romanzo bellissimo e fortunato La ricreazione è finita di Dario Ferrari che ha poi vinto molti premi (escluso lo Strega, prova inequivocabile che è un gran libro). Prima di La ricreazione è finita Ferrari aveva pubblicato un giallo dal titolo bellissimo, La quarta versione di Giuda, passato completamente sotto silenzio. Un anno dopo è arrivato il momento di dire che La quarta versione di Giuda non è meno bello di La ricreazione è finita e quindi merita la sua stessa fortuna e considerazione. In attesa del dovuto risarcimento, vediamo cosa racconta questo giallo teologico. A cominciare dal titolo.
Secondo Jorge Luis Borges (tutti in piedi!), la questione del figlio di Dio che scese sulla terra per salvarne i perfidi abitanti andò diversamente da come è stata narrata. Dio vagliò, in un primo momento, alcuni destini specchiatissimi. Considerò di assumere le fattezze del condottiero Alessandro Magno, poi dello scienziato Pitagora, quindi di Rurik, un altro condottiero, stavolta danese. Si soffermò anche su Gesù di Nazareth. Nessuno di loro resse all’esame e Dio li scartò (la scena, a volerla immaginare, somiglia a quelle in cui Diabolik prova le maschere per il prossimo camuffamento che gli permetterà di prendere l’ispettore Ginko ancora una volta per il naso).
Dio escluse queste brillantissime, stimatissime persone perché sapeva che la sua missione consisteva nel farsi uomo interamente, «fino all’infamia... fino alla dannazione e all’abisso». E così non gli restò che puntare su «un destino infimo: fu Giuda».
La quarta versione di Giuda comincia come potrebbe cominciare un romanzo di Andrea Vitali. In sacrestia.
Incipit:
«Se, pistola alla tempia, Don Tony dovesse dire quali sono le cose che più detesta del suo lavoro, non avrebbe dubbi:
1. L’alito di suor Tarcisia
2. La messa delle sette di mattina.
3. Il giovedì».
Perché il giovedì? Perché è il pomeriggio dedicato alle confessioni. E le confessioni, Don Tony, le trova pallose, piatte. Sono la cumbia della noia, diremmo oggi noi folgorati sulla via di Sanremo da Angelina Mango, suo padre (Pino) e la grande Madame (una trinità davvero interessante).
Sgombriamo il campo da illazioni pruriginose. Don Tony (vi anticipo che è un personaggio straordinario, un anti-Don Abbondio) non è un prete avido di racconti a luci rosse da parte dei suoi parrocchiani. Però non ha potuto fare a meno di notare che i fedeli che vanno a confidarsi da lui fanno assai raramente cenno ai loro desideri, comportamenti, perversioni carnali. Cosa già strana in sé e, ancora più strana, se si pensa che siamo a Viareggio, città carnevalesca in tutti i sensi della parola (approfitto dell’occasione per ricordare che anche il secondo romanzo, quello fortunatissimo, di Ferrari, La ricreazione è finita, era in gran parte ambientato nella capitale della Versilia).
Sulla questione confessioni Don Tony ha riflettuto a lungo. Ecco un esempio delle sue elucubrazioni al riguardo.
«Contro ogni previsione, però, le confessioni a cui è costretto a sottoporsi ogni giovedì pomeriggio di sessuale hanno ben poco, e quando capita di sicuro non gli fanno rimpiangere di averci rinunciato sine die. Se quindi il mondo intero ruota davvero attorno al sesso, come tutti ripetono, allora i casi sono due, anzi tre: o è tutto un sopravvalutato imbroglio freudiano a cui la gente finge di credere per spirito di omologazione; oppure il sesso è una cosa di cui in confessione si preferisce non parlare, anche perché ormai solo pochi nostalgici lo considerano un peccato; oppure il sesso è una cosa che si fa solo al di fuori della sua parrocchia».
Don Tony ha pensieri forse ai limiti della blasfemia trattandosi di un prete. Per esempio, «ogni aspetto della riproduzione della natura, dalla deposizione dell’uovo al parto di un bambino, gli sembra insopportabilmente privo del minimo sindacale di grazia».
Ma per capire il personaggio la pista sessuale serve a poco. Serve molto di più, invece, andare a casa sua verso l’ora di pranzo e buttare un’occhiata alla cambusa: «di pasta ne ha almeno 14 declinazioni, e probabilmente si butterà su un rigatone o su una mezza manica, che permettono il fondamentale effetto sorpresa, quando il cubetto di guanciale croccante si nasconde dentro la pasta».
Sì, Don Tony è un gourmet, un bon vivant. In una parola: un mangione. Sotto quella veste talare (immancabilmente cosparsa di patacche), batte il cuore di un bulimico. E anche di un sommelier. Ma non di vini pregiati, Supertuscan e simili, sarebbe banale e troppo inflazionato, bensì delle deprecabili, e quanto mai neglette dallo snobismo contemporaneo, bibite gassate. Ecco una sua splendida recensione del chinotto Neri: «il glorioso Neri, lo accarezza con uno sguardo paterno. Il chinotto perfetto: effervescente, bilanciato, persistente. Quasi troppo perfetto: un chinotto da meditazione più che da pasto. Magari lo berrà più tardi, leggendo qualcosa davanti al ronzio insipido della tv».
Vi sembra che finora Ferrari si muova nella dimensione parochial, come dicono gli inglesi, cara a Piero Chiara, Andrea Vitali (e di Andrea ci vogliamo mettere anche Camilleri?), agli eredi, insomma, della tradizione narrativa trecentesca? In realtà, il modello principale dello scrittore (dal multiforme ingegno mimetico stilistico) è un altro, come certificano gli attacchi dei paragrafi. Eccone uno.
«In un certo senso - anzi: in diversi certi sensi - posso essere considerato il migliore. Questo pensiero si formula quasi inconsciamente nella mente del dottor Ferri, pilastro (si dice) del reparto Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Versilia, nonché pilastro (si potrebbe dire) della parrocchia dei Sette Santi».
Il sound è quello inconfondibile di Fruttero & Lucentini, la coppia più bella del mondo letterario italiano (qualcuno comincia ad accorgersene, ma sono sempre troppo pochi e così continuiamo a farci del male con i colpi dello Strega).
Il dottor Ferri è uno dei personaggi del romanzo che fa più F&L. Alla stessa categoria appartiene anche il leader del centro sociale Monicelli, Francesco Primotti, che si fa chiamare Francesco Primo, pensando così di far dispetto al Papa. Questo Primotti è alle prese con un refresh del suo look e medita di scorciare un po’ la barba «e di comprare degli occhiali per sostituire la grossa montatura pentapartito con un intramontabile tondo gramsciano».
Ma quello griffato F&L più di tutti è Franco La Voce. Costui sin da bambino aveva chiara la sua vocazione: da grande voleva fare l’Eminenza grigia, colui che dietro le quinte muove le pedine della scacchiera politica, assegna incarichi, bilancia poteri, decide destini, smussa, depenna persuade, dissuade, sopisce, fomenta, trama, ricama. Oggi quel nobile ruolo che fu dei Richelieu (e dei Franco Rodano nella versione cattocomunista anni Settanta) è rivestito da scialbe figure che rispondono a nomi come Goffredo Bettini. Oppure scambiato con quello dei frigidi spin doctor buoni per tutte le stagioni. O, ancora, finito nelle mani, che lasciano molto a desiderare dal punto di vista igienico, di volgari faccendieri.
Franco La Voce fornisce ancora una interpretazione all’altezza della tradizione agendo al livello massimo, attingendo, teatralmente parlando, all’implacabilità e arbitrarietà del Deus Ex Machina.
Tra l’altro, Franco La Voce ha un talento innato e prodigioso che molto dice della sua conoscenza degli uomini. È capace di dedurre la squadra di calcio per cui fa il tifo un maschio italico incrociandone, come si fa con i meridiani e i paralleli sul mappamondo, il temperamento e il ceto. Potremmo chiamarla la tavola periodica di La Voce. Eccone una piccola dimostrazione :
«Piccolo-medio borghese senza velleità e con fantasie di sottomissione: interista. Nostalgico-narciso, anche di origine popolare: milanista. Aspirante intellettuale: dichiara di non seguire il calcio e trova immorali le cifre che girano in quel mondo vuoto. Intellettuale affermato: si svacca davanti al televisore in boxer e soffre come un cane per le sorti avverse della Roma (ma la squadra è intercambiabile, quello che non varia è che il soggetto in questione di sicuro di calcio non ci capisce una mazza, e gode solo nel sentirsi vicino al popolo)».
Volete sapere per che squadra tiene, ad esempio, il ginecologo Ferri? «Il dottore, dal canto suo, come tutti coloro che sentono di essere vincenti per una sorta di predestinazione alla supremazia, è juventino».
Ovviamente, con perfetto rispetto della tempistica gialla, c’è subito un morto e bisogna indagare. Il detective scelto da Ferrari per il suo esordio nel mystery è il commissario di polizia Klaus Russo, palemmitano di Bagheria, figlio di un appassionato di poliziotteschi (qualche titolo, tanto per rinfrescare la memoria di quel glorioso, seppure un po’ destrorso, filone cinematografico nazionale: La polizia ringrazia, La polizia incrimina, la legge assolve, La malavita attacca... la polizia risponde!), con un debole per Kinski, da cui il nome del figlio.

Il commissario Russo predilige la teoria alla pratica. Deluso dal trantran del mestiere, sogna di scrivere un romanzo giallo con protagonista un suo omologo patito di letteratura e di cucina. Russo non è uno che si improvvisa, ha studiato il genere in cui intende cimentarsi e, tra le altre cose, ha capito che un commissario letterario non può permettersi di snobbare la tavola. «Un commissario che mangia la Simmenthal non vincerà mai un premio letterario, è una regola che tutti gli addetti ai lavori conoscono».
Klaus Russo ha dosato al milligrammo gli ingredienti del suo detective (un personaggio letterario non è altro, allo stato basico, che una ricetta). Accento e fascino siculi alla Montalbano, acume sabaudo alla Santamaria, il commissario di F&L (che al cinema fu uno dei Marcelli Mastroianni più carezzevole di sempre), «una praticaccia del mondo alla Ingravallo, una empatia maigrettiana e l’inflessibilità deduttiva di August Dupin». A coronare il tutto, ciliegina sulla torta, lo stile e l’ironia di Dylan Dog.

Sa che cosa vuole il commissario Russo sul piano letterario, però mettere nero su bianco i brillanti propositi è un altro paio di maniche. Il commissario si spreme le meningi ma il suo giallo non prende colore. La moglie, poi (praticamente latitante, casalingamente parlando, e che sorprenderà il marito con un gran colpo di scena), non lo aiuta chiamandolo Dostoevskij. La presa per il culo del coniuge è plateale.
Lasciamo tranquillo il commissario Russo a cesellare l’incipit del giallo che lo riscatterebbe dalla condizione di funzionario di PS e torniamo a Don Tony e al suo scheletro nell’armadio: una ragazza fuori di testa gli si è piazzata in casa esponendolo alla riprovazione dei parrocchiani e ai sospetti degli investigatori. Intanto, però, deve fronteggiare le richieste che gli vengono da una parte dei fedeli di rendere la Chiesa più al passo con i tempi aprendo al Christian trap, alle strofe free style e alle basi fatte coi sintetizzatori al posto di canti gregoriani e di altre liturgiche anticaglie. Don Tony, l’avrete capito, è un indeciso a tutto, ma sull’argomento alza le barricate e spiega a suor Tarcisia, che simpatizza con gli innovatori, i motivi della sua idiosincrasia verso qualsiasi tipo di refresh ecclesiastico: «Il nostro target sono i bambini e vecchi, principalmente. Sono gli unici gruppi umani a cui interessi l’infinito. I giovani no. Ai giovani interessano le mode. Ma le mode passano, e la Chiesa resta: è questo il principio su cui ci siamo basati per millenni. Se ci mettiamo a inseguire le mode, il tempo ci spazzerà via. Noi non siamo una moda. A noi interessa l’eternità. Chiaro?».
Come abbiamo visto tante volte succedere a Sordi, Tognazzi, De Sica nella commedia all’italiana, anche Don Tony sarà protagonista di una metamorfosi che da macchietta lo eleverà a personaggio di dimensione quasi eroica.
La metamorfosi di Don Tony è provocata dall’amore. Un amore che, intuisce il prete, finirà tragicamente. Sconvolto dalla forza del suo sentimento, Don Tony cerca uno specchio in cui guardare l’immagine nuova di sé stesso, cerca parole che gliela illustrino. Ma non trova conforto nei migliori cantori dell’amore. Non lo trova nel Cantico dei Cantici, non lo trova in Guido Cavalcanti, non lo trova in Federico García Lorca, non lo trova in Jacques Prévert (Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte / Il primo per vederti tutto il viso / Il secondo per vederti gli occhi / L’ultimo per vedere la tua bocca / E tutto il buio per ricordarmi queste cose / Mentre ti stringo fra le braccia). No, l’unico che riflette la complessità del suo stato d’animo «è, in tutta la sua imbarazzante evidenza, Michele Zarrillo». Non c’è niente da fare, il canone dell’amore anche a Viareggio come nel resto d’Italia è sanremese.
A questo punto vi lamenterete perché ho detto finora poco o nulla sull’aspetto propriamente giallo della vicenda perdendomi in divagazioni sentimentali, liturgiche, futbolístiche, canzonettistiche, politiche. È una giusta lamentela e corro ai ripari chiamando in aiuto il più informato di tutti in materia: il commissario Klaus Russo. Ecco i suoi pensamenti sullo stato delle indagini (impreziositi, com’è suo costume, da raffinati rimandi letterari).
«Il caso è ingarbugliato, si dice infine a mo’ di conclusione. Delle persone che ho davanti, pensa concedendo forse un po’ troppo alla letteratura, non ce n’è una che sembra essere ciò che mostra. Ognuno ha dei segreti, ognuno appare per ciò che non è. Ognuno, inoltre, potrebbe avere una sua rilevanza drammatica. Se fossimo in un romanzo di Fruttero e Lucentini, riflette, saprei di dover indagare senza indugi in direzione del signor La Voce e del sindaco Medioli. Se fossimo in un romanzo di Camilleri, ci sarebbe senz’altro da approfondire il rapporto tra questa moglie algida e quell’avvocato scaltro, mentre se fossimo in un romanzo di Sciascia quel prete di sicuro non ce la conterebbe giusta.
Ma chi lo sa, in che mani siamo? Se solo conoscessimo l’autore delle nostre vite, o quantomeno il genere letterario cui esse appartengono, sarebbe tutto più semplice. Uno si preparerebbe, in un certo senso, delle azioni e delle reazioni commisurate. Sono il protagonista di una commedia americana con lieto fine garantito oppure di un film neorealista in bianco e nero? Sono il comprimario di una falsa zigana alla Kusturica oppure di un drammone depressivo di Lars von Trier?
Sappiamo già in partenza che alla fine le nostre vicende ci insegneranno una morale, oppure siamo alla mercé degli eventi, picari sbattuti qua e là da eventi casuali e imprevedibili? Ma così, senza sapere a che genere letterario fa capo la nostra storia, come si fa a decidere come comportarsi? Come si fa a sapere se è meglio essere istrionici o impulsivi, cinici o romantici? Se essere generosi o spietati? E soprattutto come si fa a non finire per essere delle comparse trascurabili? Uno magari fa di tutto per essere un perfetto Adamsberg; ma se poi finisce in una storia di Stieg Larsson? O di Stephen King? Prendi questo delitto di provincia: e se d’improvviso si trasformasse in un hard boiled? O in un lambiccatissimo gioco di specchi alla John le Carré? Ma, soprattutto, chi glielo spiega al questore che sto seguendo una pista dal retrogusto simenoniano anziché L’unica pista che secondo lui porta a risolvere qualche caso reale, ovvero quella delle statistiche ministeriali?».
E così anche il personaggio del commissario da silhouette macchiettistica assurge alla tridimensionalità del pensatore rodiniano e pronuncia una grande verità: se la vita fosse un genere letterario tutto sarebbe più semplice.
Disposizioni finali (e non transitorie)
La quarta versione di Giuda, il primo romanzo di Dario Ferrari conteneva già molte delle qualità che hanno poi decretato il successo del successivo La ricreazione è finita. Quindi chi ha apprezzato il secondo può fare tranquillamente il bis con il primo.
Il modo in cui Ferrari racconta Viareggio, e soprattutto il cuore della città, la Darsena, mi ha ricordato un pomeriggio di luglio di tanti anni fa quando intervistai Manlio Cancogni fresco vincitore del Premio Viareggio. Eravamo seduti su una panchina sul lungomare davanti al Grand Hotel Principe di Piemonte. Cancogni mi parlò delle cose che aveva visto e vissuto in quelle zone: la guerra, la Linea Gotica, gli eccidi, Ezra Pound chiuso in una gabbia come gli orsi alle fiere di una volta, come un abominevole uomo delle nevi finalmente catturato. Mi parlò dei suoi romanzi che distingueva tra quelli “ormai scotti” e quelli “ancora al dente”. Mi parlò di Valentino Mazzola e del Grande Torino. Mi parlò del primo serial killer italiano che agiva a Sarzana dove Cancogni insegnava al liceo...
Era la prima volta che il grande scrittore mi parlava degli argomenti che sarebbero stati poi quelli di tante nostre conversazioni (ma io tacevo, il bello era ascoltare quel narratore agitato e incessante come le onde del mare). Fu anche la prima volta che Cancogni mi mostrò la Bella Dormiente, la figura di ragazza sdraiata che da Viareggio si vede disegnata inconfondibilmente contro il cielo dalle cime delle Apuane. E da allora me la mostrò ogni volta che ci ritrovammo da quelle parti.
Mi manca tanto Cancogni e ancora mi capita di pensare: adesso lo chiamo e gli dico che vado a trovarlo a Fiumetto.
Quella volta sul lungomare Cancogni fu restio soltanto sulla amicizia che lo legò in giovinezza a Carlo Cassola, una delle più forti amicizie nella storia della letteratura (non solo italiana) poi finita di colpo e non si è mai saputa la causa, senza un vero perché. Non me lo disse nemmeno quel pomeriggio sulla panchina il perché, però si dilungò su una teoria sua e di Cassola, una teoria originale e controcorrente nell’ambiente letterario del dopoguerra. Secondo Cancogni e Cassola, il vero, immenso James Joyce stava non nel venerato e venerabile Ulysses, il romanzo che cambiò per sempre il modo di scrivere i romanzi, ma nei Dubliners, i racconti in cui lo scrittore irlandese immortalò la sua città. Quando non era in giro per il mondo, quando non soggiornava per lunghi periodi in America o nelle principali capitali d’Europa, Cancogni viveva a Fiumetto nella cosiddetta Versilia Storica. E io penso che, per contiguità territoriale, la preferenza di Cancogni per i Dubliners abbia contagiato il gusto narrativo del suo compaesano Dario Ferrari. Don Tony è un personaggio che nei Dubliners avrebbe fatto la sua porca (detto affettuosamente) figura.
P.S. Mentre sfogliavo Google alla ricerca di una immagine della villetta di Cancogni, ho trovato una vecchia cronaca di una partita di calcio del Campionato Allievi Regionali. Penso che a Manlio, grande patito di calcio (il pallone gli rese meno grave la vita nei suoi ultimi anni, ma questa è un’altra delle sue tante storie da raccontare un’altra volta), questa cronaca sarebbe piaciuta, lo avrebbe fatto sorridere. Ne riporto le prime righe: «Frena ancora il Lido di Camaiore, fermato in casa sul pari da un buon Seravezza. Nonostante i gialloblù non offrano una delle loro migliori prestazioni, è un 1-1 che sa di beffa per il Lido, raggiunto nel finale dal gol di De Angeli. Mister Del Chiaro ridisegna la squadra per far fronte alle diverse assenze; il Lido di Camaiore parte bene e riesce subito a sbloccare la partita. È Cancogni a firmare l’1-0 spingendo in rete un pallone rimasto pericolosamente in area dopo un paio di respinte…».
Ho abbondato di riferimenti ad altri scrittori parlando di La quarta versione di Giuda e avevo fatto lo stesso quando ho parlato di La ricreazione è finita. Ma dopo avere detto che Ferrari fruttero&lucentineggia (nel senso di Carlo & Franco), vitaleggia (nel senso di Andrea), camillereggia (nel senso dell’altro Andrea), chiareggia (nel senso di Piero), sciascieggia (nel senso di Leonardo) eccetera eccetera, non vorrei essere frainteso e non vorrei che non gli fosse riconosciuta la sua originalità e autenticità. Dario Ferrari, soprattutto, ferrareggia (e lo fa alla grande).
Ovviamente, come già lo furono i Dubliners per Dublino, La quarta versione di Giuda può essere anche un’ottima guida turistica per Viareggio. Volete prendere un caffè in zona? Allora sappiate che «il migliore di Viareggio, tre cucchiaini della guida Michelin», si beve al Circolo Ricreativo Operaio, il mitico CRO in Darsena.
Ai critici che vi diranno che c’è una eccessiva escursione termica tra umorismo e tragedia nei romanzi di Ferrari, rispondete pure che è vero. E non aggiungete altro.
Sempre a questi critici potete dire che il giallo di Ferrari è un giallo teologico di impronta borgesiana, l’unico vero teologo dei nostri tempi. E vedrete che non diranno più una parola sconvolti dalla fortissima escursione termica contenuta nella vostra affermazione.
La più bella battuta (ma sono tante che potrebbero aspirare al titolo) di La quarta versione di Giuda è di Carini, l’assistente romanaccio del commissario Russo, e potrebbe essere un ottimo slogan per una pubblicità comparata della Ferrarelle (dopo l’imbattibile tormentone “Liscia, gassata o...”). Dice Carini: «’St’acqua gassata che c’hanno in alta Italia nun se po’ bbeve».
All’inizio del libro Ferrari appone una frase di Silvio D’Arzo (scrittore da leggere se non lo avete ancora letto) che dice: «Un assurdo prete: un’assurda vecchia: tutta un’assurda storia da un soldo». Che il primissimo germe di La quarta versione di Giuda sia in quella frase dello scrittore modenese? Sia come sia non è comunque una storia da un soldo.
P.P.S. il piatto che consiglio di abbinare alla lettura è la tartare di cuore dello chef Matteo Fronduti del ristorante Manna.
Il voto è 9.






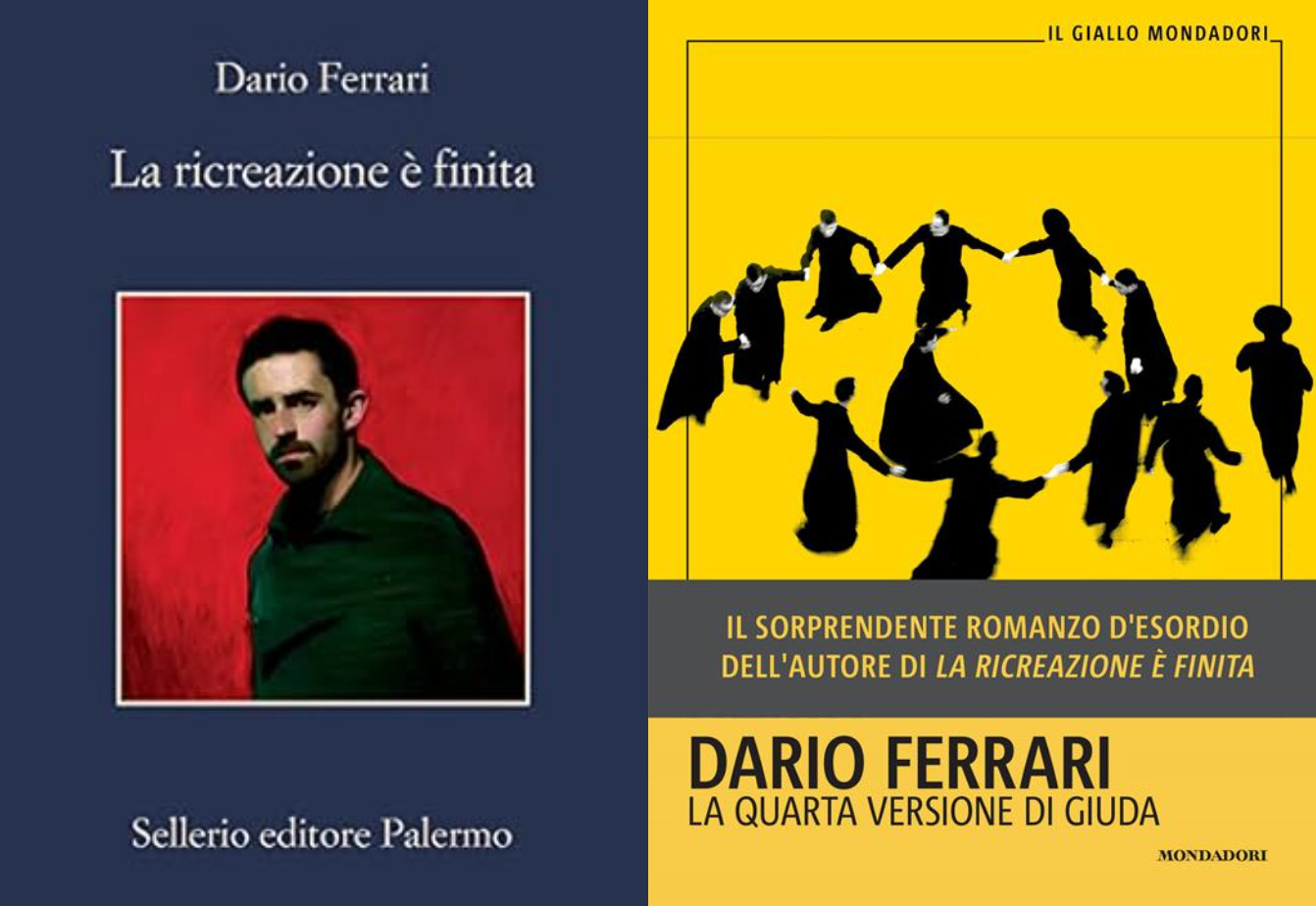










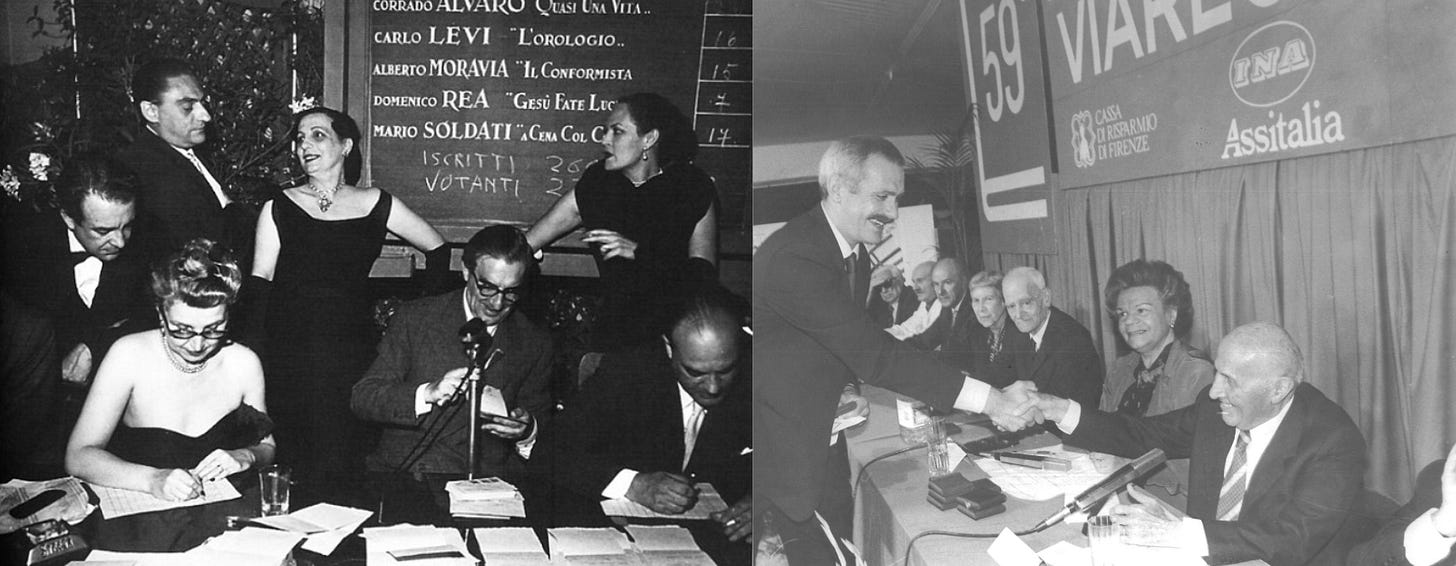



Grazie mille per la Sua super pagella. Veramente è sempre una bellissima sorpresa trovarla nella posta.
Aspetto la prossima intanto vado in biblioteca a cercare i libri.
Sono sempre rapita dai suoi commenti e racconti. Infine mi ha fatto venire una grande nostalgia di Fruttero&Lucentini